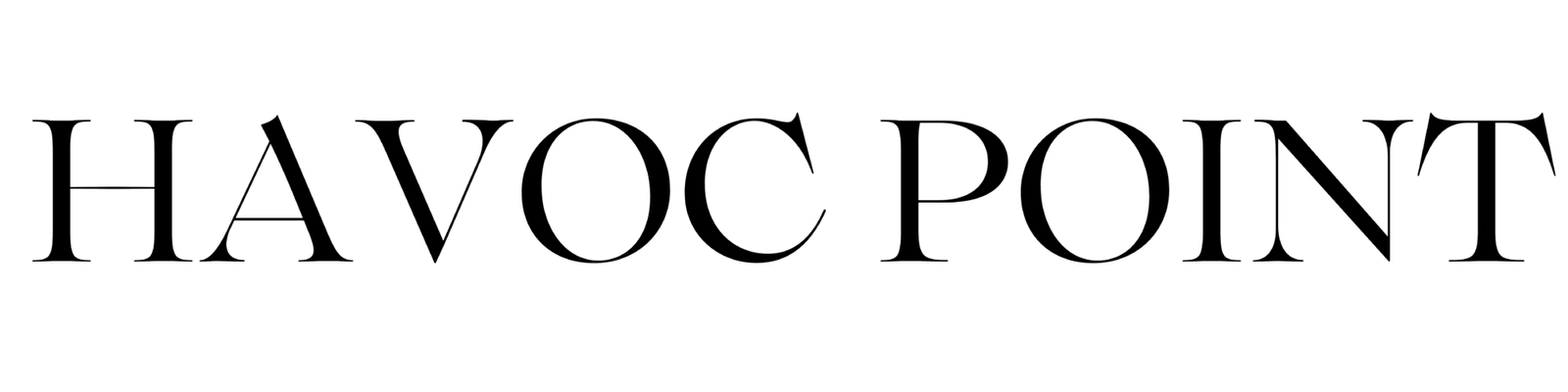Questo sito contiene diversi annunci Amazon. A ogni vostro acquisto riceviamo una piccola commissione.
Era il 2012 quando Detroit ha fatto capolino per la prima volta dentro i nostri occhi. Ce lo ricordiamo bene.
Non si può certo dimenticare il giorno in cui David Cage, un po’ a sorpresa, proponeva al mondo una tech demo, un cortometraggio di rara bellezza, basato sulla nascita di un androide che avrebbe stregato i cuori di milioni di appassionati di cinema e videogiochi con i suoi occhioni così vividi e ammalianti. Il suo nome all’epoca era solo “Kara”, di questa Detroit ancora in realtà non c’era nemmeno l’ombra, perché il capo dei francesi Quantic Dream in realtà stava pensando a tutt’altro, ancora aveva da far nascere la sua successiva creatura videoludica, la quale avrebbe visto i natali giusto due anni dopo proprio su Playstation 3. Console che così bene aveva accolto il regista con la sua prima opera esclusiva prodotta per la casa giapponese, quell’ Heavy Rain che ancora molti portano nel cuore.
Kara all’epoca era quindi solamente una demo tecnica capace di mostrare la potenza dell’engine, e ci si ricorda così bene di lei perchè, nonostante all’epoca nulla lo facesse intendere, inconsapevolmente ogni appassionato aveva iniziato segretamente a sperare che qualcosa stesse davvero bollendo nella pentola dei Quantic. Qualcosa che andasse a sviscerare il concetto di umanità, ribaltandolo in un contesto futuristico dove gli androidi stessero davvero combattendo con quella loro natura artificiale, assecondando il risveglio di quella componente divina innata, a cui diamo il nome di anima. C’era tanta voglia di questo.

Ma per averlo abbiamo dovuto aspettare ben sei lunghi anni. Anni così lunghi da farci divorare qualunque tipo di contenuto mediatico a tema AI in compagnia del pensiero, “Che fine avrà fatto Kara?”.
E dopo tutta questa attesa non vedevamo davvero l’ora di capire quanto a fondo si sia davvero riusciti a scavare, per arrivare a capire se delle semplici macchine possono davvero arrivare a sentirsi umane.
L’opera di David Cage partiva con delle premesse di una certa rilevanza. Come avete potuto capire dall’introduzione quel corto buttato in pasto alla folla di gamer era riuscito a creare già tutta una serie di aspettative quando ancora nulla, del codice di Detroit, era stato nemmeno steso.
Aspettative che, possiamo dire, sono state rispettate. Come, al contempo, possiamo dire che sono state invece disattese. Nulla di questa ambigua valutazione potrà comunque togliere a Detroit un solo grammo di quel che in definitiva, e senza mezzi termini, è, ovvero: un prodotto assolutamente magnifico.
Il titolo di Quantic Dream è l’evidente culmine di un processo evolutivo che ha investito il genere delle avventure grafiche moderne nel corso dell’ultima decade. Raccogliendo l’embrione gettato nel 2005 con Fahrenheit, si può finalmente dire che quell’idea di videogioco sia finalmente arrivata ad una forma tangibile e compiuta. L’idea di racconto interattivo, il quale plasma il suo percorso sulla base delle scelte compiute dal giocatore, esce finalmente dal quell’utero in cui si continuava a dimenare già convinto di aver trovato la sua definitiva forma, eppure mai capace di convincere i giocatori per intero. Detroit, con la sua essenza, ci consegna invece quello che è un vero e proprio nuovo capitolo uno. Un punto di partenza capace di ridefinire il concetto di causalità. Il processo di cui si fregia per convincere il giocatore della sua influenza sulla trama è, in realtà, una lama che si rivela incredibilmente a doppio taglio. Detroit stupisce, disillude, per poi rapire completamente e definitivamente. Lo fa con quell’albero di scelte mostrato alla fine di ogni capitolo. Uno strumento capace di farci vedere dall’alto quanto le nostre scelte avrebbero potuto portare a differenti versioni della stessa storia. E inizialmente la sensazione, data la mole di alternative, è assolutamente inebriante.

Già dal primo capitolo, in cui vestiremo i panni dell’agente/androide Connor, sperimento l’estrema responsività del mondo di gioco. La scena in cui si è immersi viaggia in una dimensione di tempo credibile, che non pone il mondo in stasi in attesa delle scelte del giocatore. La storia va avanti, e se non fai qualcosa, ci saranno comunque delle conseguenze (e non saranno certo positive).
Questa dimensione videoludica è così ben costruita che però, paradossalmente, dopo alcuni quadri, arriva a ad essere sminuita da quell’albero sparato lì alla fine di ogni parte di racconto. Detroit costruisce così bene l’illusione di una consequenzialità assoluta che l’atto di rivelare i suoi limiti naturali in realtà finisce per smontare l’idea romantica della totale libertà narrativa, sensazione assurda, ma che il gioco riesce in realtà a generare. Mostrare le sbarre di una prigione, per quanto ampia, ne rivela comunque la natura.
Nonostante questo piccolo auto-gol la potenza di Detroit è tale che riesce a farti digerire il tutto, riconsegnandoti lindo e pulito a quel mondo in cui si percepisce nettamente (grazie anche a dei quick time event mai così sfidanti) che scelte e tempo, sono il fattore essenziale per un progredimento che rimane totalmente nelle nostre mani, e che torna a rendere nuovamente invisibili quelle sbarre.

L’eterogeneità della mole di scelte, dalle più influenti alle più particellari, crea finalmente quella fusione equilibrata tra regista e giocatore, al punto tale da far convergere il concetto di visione originale e possibilità decisionale.
La stessa città di Detroit e lo stesso gioco sembrano rispondere alle nostre scelte, che sia per l’indugiare davanti ad un paninaro che non vuole avere a che fare con noi e che ci invita poco gentilmente ad andarcene, o il semplice benvenuto dato dal menù che va ad assumere le sembianze di un androide d’accoglienza e ci sottopone ogni tanto piccoli sondaggi a cui rispondere. L’immersività viene garantita anche dall’abile utilizzo che lo studio fa del controller di Playstation 4, il quale viene trattato dal come un vero organo esteso del giocatore, deputando ogni azione videoludica ad una corrispettiva reazione su di esso, sempre pensata e funzionale. L’utilizzo delle gesture sul touch pad, solo in determinati momenti, fa capire quanto questo tipo di meccanica assuma un valore pensato nell’economia generale dell’ esperienziale. Con tutto questo David Cage riesce finalmente a raggiungere la sua ambizione: quella di creare una dimensione interattivo-narrativa credibilmente responsiva.
Se la costruzione di questa dimensione riesce finalmente in maniera quasi perfetta, la narrazione è forse l’aspetto che, in Detroit, porta al prodotto alcune incertezze. Incertezze che si arrivano a percepire, ma non arrivano mai a minare le qualità di un prodotto che, anche da quel punto di vista, rimane di altissimo livello. È anzi forse quel suo volare così in alto che mette in luce dei difetti che nemmeno sono tali nella loro natura ma che giocando a livelli così elevati, in termini di contenuto e realizzazione, lo diventano per via indiretta.
Entrando più nel dettaglio, l’opera di Cage, riesce a creare una storia incredibilmente ben orchestrata, composta dai segmenti alternati degli androidi che impersoneremo, pensati per comunicare vissuti ed emozioni ben distinte, tutte necessarie a quello che Detroit, nel suo complesso come prodotto, vuole andare a trasmettere. C’è la storia più intima ed umana di Kara e della sua fuga con una bambina che proteggerà come una figlia. C’è il percorso di amicizia e di fiducia di Connor e Hank. E c’è la battaglia etica di Marcus, vero portavoce della causa androide. Il menù si può dire più che completo, e i personaggi stessi risultano caratterizzati ottimamente; riescono in breve tempo a empatizzare con il giocatore, che ne segue con interesse ed emozione crescente le vicende. Lunghi tratti di queste storie hanno uno sviluppo pressochè perfetto, basti pensare, in caso si riesca a percorrere quella soluzione narrativa per intero, all’accrescimento graduale della fiducia di Hank verso Connor: la costruzione del loro rapporto di amicizia può essere identificato come il vero e proprio asse portante di quest’opera, un vero e proprio gioiello. Come un gioiello rimane il racconto che il mondo fa al giocare nel suo vagare. David Cage per la prima volta si prende il coraggio di costruire un mondo con una narrativa fatta di dettagli originali ed intriganti, che pescano appieno dai classici della fantascienza, ma che rielabora e inserisce con perizia, rendendo il viaggio in questa Detroit futuristica una continua scoperta, sia dal lato più sociologico, sia dal lato umanistico.

La verità è all’interno. The truth is inside. Il gioco di mistero, a tinte introspettive, in cui ci si tenta di inserire funziona davvero per lunghi tratti, e il conflitto esistenziale degli androidi che andremo a vivere trova sbocchi di grande impatto, grazie soprattutto ad una regia mai così dinamica, reattiva e puntale.
La regia però copre della falle che è impossibile non avvertire arrivati a questo livello. Se nel suo imbastimento generale, e nei suoi momenti più eclatanti, Detroit si avvale di una scrittura attenta e decisa, lo stesso non si può dire di tutto il suo narrato. È triste denotare come a momenti alterni il racconto si faccia invece decisamente più superficiale (la villa è sicuramente il momento meno azzeccato di tutta l’esperienza). L’analisi emotiva del conflitto interno avvertito dagli androidi molte volte non viene sviscerato a sufficienza, generando passaggi drammatici decisamente affrettati. Usando come semplice riferimento l’impatto avuto dal corto “Kara”, si avverte ancor meglio dove sta la mancanza di quest’opera che, come già successo con maggiore gravosità in Beyond:Two Soul, parla troppo di emotività, di anima, la inscena in maniera perfetta, ma fallisce nel compito di farla transitare vero il giocatore, proprio a causa della sua mancanza di attenzione verso le tempistiche necessarie che vanno concesse all’introspezione. Dove le trovate visive riescono (il passaggio da androide a deviante è davvero azzeccatissimo) le soluzioni di sceneggiatura invece scarseggiano, diminuendo così di molto il grado di profondità delle riflessioni. Non sarebbe nemmeno così di ostacolo il fatto che il mondo di Detroit mostri una divisione così netta fra androidi buoni e umani cattivi. Se non per il fatto che a questo non si aggiunge un’attenzione necessaria votata a sottolineare quanto gli androidi siano differenti dagli umani, nel modo di pensare e di agire. Sembra di trovarsi di fronte a una “razza” nemmeno troppo in conflitto con sé stessa, né in fase di reale ricerca di questa umanità nascosta nel suo codice. La narrazione procedere in maniera semplicistica trattandola come se fosse una qualunque etnia che rivendica i propri diritti di libertà, tralasciando tutte quelle differenze che, se sottolineate a dovere, avrebbero ancor più messo in risalto i momenti di incontro fra “le razze” dati dall’umanità insita in ogni androide. Scelte che in sé e per sé non sono dei veri e propri errori, ma sono soluzioni sicuramente dalla minor efficacia, e ci sottraggono tutto quello di cui volevamo sentir parlare da quando abbiamo messo gli occhi su quel corto, che in soli 7 minuti riesce a trasmettere più emozione condensata che Detroit nelle sue 10 e passa ore di gioco.
Pur all’apice del suo percorso David Cage con Detroit forse mette ancora più in evidenza il suo limite principale. Quello che Fahrenheit nascondeva con le sue novità, Heavy Rain attutiva con la sua bellezza scenica e i suoi colpi di scena, Beyond sviava con la sua mediocrità generale: la mancanza di una propria firma. Il limite autoriale di Cage sta proprio nel non essere attualmente in possesso di quella capacità che vorrebbe nell’imprimere nei suoi lavori quella carica emotiva che solo una forte firma autoriale, con propri tratti e originalità, solitamente permette. L’alternanza dei generei a cui sottopone il suo studio non aiuta certo questo tipo di processo: passare da un action/fantasy, ad un thriller, ad un racconto sovrannaturale, e ora al genere fantascientifico, forse non gli hanno permesso a dovere di esplorare i vari generi a dovere, impedendogli di trovare il modo di inserire la sua visione e il suo personale tratto in maniera inequivocabilmente vincente.Se notate dell’amaro nel finale in queste parole, possiamo confermare che si tratta comunque di un amaro pregno di gioia.

Detroit nella sua mostruosa bellezza scenica e registica, nella sua rigiocabilità, nella sua organicità, ed anche nelle sue lievi incertezze, riesce ad essere un’esperienza assolutamente unica nel panorama videoludico, a tanto così dall’olimpo dell’eccellenza e della perfezione.
Quello che fa di realmente importante, a prescindere da quanto di ottimo mostrato, è consegnare al medium videoludico un nuovo standard, una nuova alba nelle avventure narrative, che possa permettere a chi verrà dopo di tenerlo come metro di paragone in termini di reattività storica nei confronti delle scelte del giocatore.
La prossima generazione di videogiochi dovrà ripartire da qui. Da quell’ esperienza così unica che si prova nel sentirsi al centro di un universo di scelte e delle loro relative conseguenze. Dall’illusione del possibilismo più spinto in cui immergere il giocatore, co-narratore dell’opera. Non tralasciando però quell’impronta autoriale necessaria per permettere ad una storia, per quanto ben inscenata, di infilarsi all’interno del proprio cuore.
[amazon_link asins=’B071JYSFH9,B07DWSPJTX’ template=’ProductCarousel’ store=’havocpoint-21′ marketplace=’IT’ link_id=’ba77fa1b-c81a-11e8-8a94-4d6b51e76b11′]