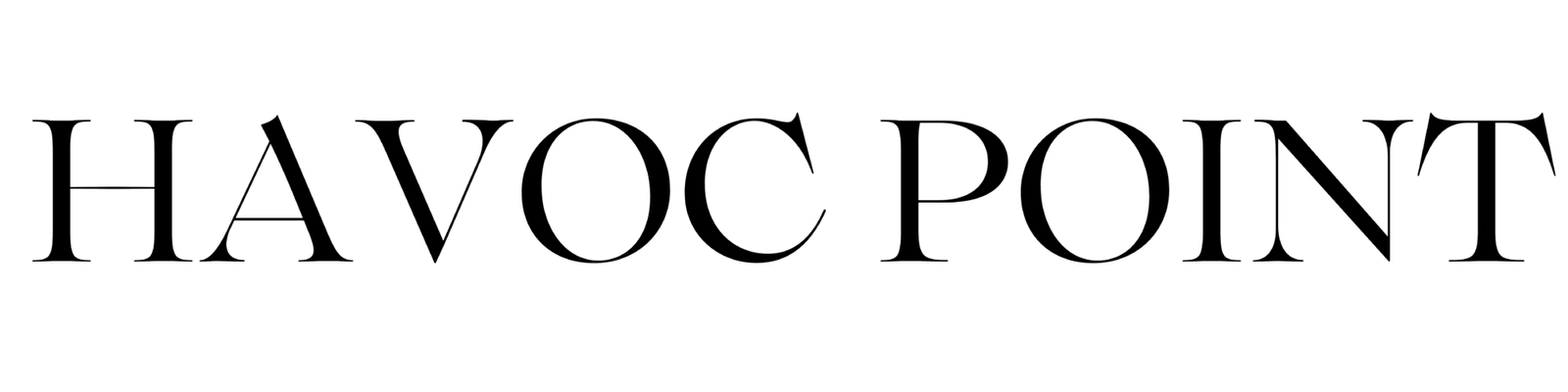Questo sito contiene diversi annunci Amazon. A ogni vostro acquisto riceviamo una piccola commissione.
La realtà virtuale è diventata per Sony certamente un mercato di importanza rilevante. Grande responsabilità del suo andamento, con il suo più di un milione di unità vendute di Playstation VR, il parco titoli proposto dagli studios da sempre vicini alla casa, vero e proprio sangue buono in un corpo ancora gracile. Il peso di queste esclusive si riflette, oltre che sull’ampliamento della già solidissima base installata, anche sul mantenimento della clientela acquisita, scongiurando il più possibile il rischio che i visori piazzati rimangano nella bellissima loggia a difendersi dalla polvere. Non solo questo: i team interni servono anche a scongiurare il consolidamento dei rumoreggiamenti dell’ambiente, che associano le esperienze in realtà virtuale ad esperienze sempliciotte, principalmente relegate al mercato indipendente.
Supermassive Games, assieme ad altri, gioca quindi un ruolo focale in questa economia interna: forte della produzione dell’ottima esclusiva Until Dawn, il team si è riuscito a creare una fan base propensa a rinnovare la fiducia concessa, e lo sbarco in realtà virtuale dello spin off Rush of Blood (sempre a loro cura), ha dimostrato definitivamente come essa sia stata ben riposta, dimostrando inoltre una certa sagacità nel plasmare un brand che aveva meccaniche totalmente differenti ad un nuovo mezzo di fruizione. Questo accadeva però al lancio di Playstation VR, nell’ormai lontano 2016. Con il trascorrere del tempo i buoni risultati raccolti con questo primo esperimento hanno iniettato delle speranze di crescita tutt’altro che banali; chiunque vedendo quel tipo di esordio non poteva che riporre una fiducia quasi incondizionata nel prossimo lavoro di cui si sarebbero fatti carico, convinti che il tempo non avrebbe fatto altro che aiutare lo studio a comprendere ancor meglio il nuovo mezzo di fruizione, per preparare così lo sbarco di un titolo che sarebbe stato capace di dare una marcia in più alle esperienze casco alla testa. Un po’ meno magari di quello che è stato Resident Evil 7, molto di più di quanto già visto in tutte le piccole opere che fino ad ora hanno costellato il vasto parco titoli di Playstation VR.
Ed ecco che a Giugno 2017 finalmente salta fuori il trailer di The Inpatient, titolo in soggettiva (senza binari) che avrebbe dovuto addirittura sobbarcarsi l’onere e l’onore di fungere da vero e proprio prequel di Until Dawn. Non penso serva rimarcare il brivido di esaltazione provato in quel momento. Lo stesso brivido che non ha fatto altro che rimarcare le già alte aspettative.
Saranno state rispettate?

L’atmosfera non basta
Il titolo ci riporta negli anni 50’, in un manicomio criminale nel quale sarà interamente ambientata la vicenda. L’inscenamento già dai primi minuti si dimostra ricco di quell’atmosfera claustrofobica e dissennata di cui i Supermassive sono maestri. Le atmosfere malate e stranianti saranno la vera base narrativa del titolo, che di contraltare relega la storia principale al consueto shock mnemonico che lascia il nostro personaggio in balia degli strani eventi che iniziano a verificarsi al di fuori dalla sua cella. La formula inizialmente funziona, grazie anche alla condivisione della nostra camera con un altro paziente con il quale si tenterà di ricostruire quello che è successo, congiungendo i vari frammenti; alla ricetta ovviamente non potevano mancare saltuari e confusionari flash back. La vista di un campo innevato, data da una piccola finestra presente all’interno della stanza, è tutto quello che ci ricorda che esiste ancora un mondo al di fuori delle grigie mura dell’istituto, piccolo dettaglio che riesce a creare una certa distonia ambientale sicuramente efficace.
E’ triste però constatare come quanto di buono creato in fase di atmosfera non si concretizzi in alcun modo in termini di interesse e coinvolgimento; l’eccessiva frammentazione delle informazioni, il miscuglio con i vari flash back, non fa altro che confondere lo stile dell’opera (di derivazione horror) con quella del mind-fuck peggio sceneggiato, che da un lato si gode l’effetto di mistero e confusione generati nel giocatore, mentre dall’altro soffre del principale scotto di questo genere quando la storia non è costruita come si deve, provocando noia e disinteresse. Contaminazione derivante forse anche dalle influenze raccolte con Rush of Blood (che qui si puntavano a mantenere, magari come collante indiretto), ma che stanno portando i Supermassive su una strada meno efficace di quella a cui questo brand inizialmente, con il suo stile semplice e definito, poteva sicuramente ambire. In definitiva solo le sequenze dove la tensione la fa da padrone in attesa degli improvvisi (anche se molto limitati) jump scare, diventano il motivo per continuare l’avventura fino ai suoi titoli di coda.

La realtà virtuale non basta
A livello di gameplay l’opera si inquadra come un walking simulator nudo e crudo. Sarà possibile infatti camminare totalmente slegati da binari affidandoci ad un sistema di controllo sicuramente intelligente (praticamente obbligatorio l’utilizzo dei Move), quanto a tratti leggermente legnoso. Non si può però definirsi soddisfatti di come tutte le componenti si intreccino fra loro. Il walking simulator è un genere che con la realtà virtuale può vivere di una seconda giovinezza, ma che in questo caso mette in luce tutti i suoi difetti, tenendo i suoi pregi per sé. La lentezza che si prova nel muoversi non spinge il giocatore a godersi per intero le atmosfere ambientali (ambienti comunque di dimensione contenuta e abbastanza uguali a loro stessi), che in assenza di una trama granchè interessante sarebbero dovute essere un elemento da avvalorare in maniera più decisa. Anche perché un titolo per realtà virtuale che fallisce nel far visitare il suo mondo, possiamo dire che fallisca nella sua caratteristica più essenziale.
Di pregevole, oltre al proseguire dritto curiosando con lo sguardo qua e là, rimane la simpatica trovata con cui al giocatore viene permesso di recitare i dialoghi a scelta multipla proposti nei vari intermezzi, soluzione che aumenta piacevolmente la sensazione di immersività. Non si può dire che ciò però sia pienamente sufficiente, soprattutto considerando gli anni ormai passati dall’innesto di questo tipo di tecnologia. L’effetto “wow” dato dal semplice trovarsi all’interno dell’ambiente è arrivato alla sua naturale scadenza, e per proporre titoli con queste formule è necessario concedere concretamente qualcosa al giocatore. Il palato inizia a farsi fino, considerando anche che chi è in possesso di un Playstation VR probabilmente ha già visto girare esperienza ludiche come Farpoint, Resident Evil 7, per non citare la miriade di piccole perle proposte del panorama indipendente. The Inpatient avrebbe avuto senso nel 2016, ma ad oggi rimane un titolo che non si impegna per far emergere se stesso, né il medium di cui si fa portavoce, consegnando il suo “compitino”. Come ultima nota positiva rimane la pulizia grafica della scena mostrata soprattutto nelle sequenze di intermezzo, la quale si assesta leggermente sopra la media di genere, anche se gli ambienti risultano abbastanza spogli di dettagli.